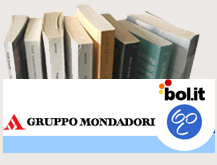Libri: " I giovani di Mussolini fascisti convinti fascisti pentiti antifascisti "
Libri: " I giovani di Mussolini fascisti convinti fascisti pentiti antifascisti "
.jpg)
Baldini&Castoldi, Milano 2001, pp.376
Erano nati o cresciuti durante il fascismo e avrebbero dovuto costituire, nelle intenzioni del regime, la futura classe dirigente dell’Italia di Mussolini. Parteciparono, quasi tutti, ai littoriali della cultura e dell’arte, istituiti a partire dal 1934 a Firenze e destinati a raccogliere il fior fiore della gioventù intellettuale in camicia nera. Dovevano essere fascisti naturaliter e invece, per molti di loro, le tormentate vicende dei vent’anni di regime li fecero approdare a sponde diverse, addirittura opposte, a quella da dove erano partiti. In molti, tra , una volta finita la guerra ebbero come un senso di vergogna nel raccontare l’esperienza di quel viaggio viste le accuse di chi rimproverava loro d’essere stati fascisti. Ben altre erano, invece, le responsabilità e ben altri, ovviamente, i responsabili dell’avvento e del consolidamento della dittatura. Questo libro è il primo che raccoglie le testimonianze della gioventù del Ventennio abbracciando sia coloro che fascisti furono e continuarono a esserlo fino a Salò, sia quelli che, invece, fascisti non furono mai. Tra i due estremi, una infinità di sfumature. Si va dai fascisti convinti ai fascisti pentiti, dai fascisti disincantati a quelli delusi, dai dissimulatori agli antifascisti, dai cattolici agli ebrei, dai letterati agli artisti, per finire con le donne, anche loro giovani e intellettuali, anche loro littrici e coinvolte nella tragedia di quella che Indro Montanelli definì la generazione dei littoriali, una delle migliori e delle più sfortunate che l’Italia abbia mai avuto: sfortunata non dal punto di vista pratico, a parte quelli che dovevano morire in guerra o nella Resistenza; sfortunata non personalmente, perché i superstiti hanno fatto ognuno la propria strada, ma sfortunata moralmente, per aver provato esperienze che lasciano il segno. Ancora oggi, a distanza di cinquant’anni da quel lungo viaggio attraverso il fascismo che Ruggero Zangrandi intraprese e poi pubblicò nel 1946 e nel 1962, il problema è non tanto di conoscere se gli italiani siano stati o meno fascisti, quanto perché così tanti poterono esserlo